Il personale è politico
– Carol Hanisch
Non esiste innocenza in questa lingua
– Antonella Anedda
Democracy simply doesen’t work
– Kent Brockman
Sempre più spesso mi ritrovo a scrivere per esperire un disagio. Si tratta di una condizione estremamente personale e di cui in certo momenti provo un certo grado di vergogna.
È allora che si tenta di superare questa propria primordiale vergogna per incanalare il proprio disagio in un ordine: talvolta tocca pure comunicarlo per spiegarselo meglio. Quantomeno per avviare un processo di autoanalisi che non sarà in un alcun modo catartico – anzi, invero può essere autodistruttivo – ma che possa dare conto di Esistere psichicamente, come scriveva un grande poeta dall’accento veneto qualche decennio fa.[1]
Avere un disagio significa anzitutto segnalare a sé stessi di avere una mancanza. Le mancanze dovrebbero celare desideri, ma de-siderare significa vedere troppo in là, troppo in alto. Stelle e costellazioni paiono irraggiungibili, l’in-fanzia che li vedeva come in un gioco sembra una condizione alla quale si ambisce a ritornare, ma anche la regressione sembra richiedere forza. La questione in gioco è dunque l’impotenza.
Qualche giorno fa, in vista delle venture Elezioni Europee, scambiavo qualche messaggio con M., cui chiedevo delucidazioni per il voto. Non esiste atto peggiore del non votare, del non scegliere – di ritirarsi, cioè, dal rito collettivo[2] o della polis che delega chi discuterà le decisioni migliori per loro. O una soglia che preannuncia un prosciugamento del mio ordine simbolico[3]. M. in particolare mi redarguiva, con tono giustamente acceso, sulla necessità di questo voto. Non posso negare che M. avesse a tutti gli effetti ragione. Of course, but maybe…maybe… (bambini allergici alle noci).[4]
L’orizzonte dietro a questo voto pare definitivamente mettere in atto un piano diabolico. Si potrebbe riassumere nella celeberrima locuzione di Margaret Thatcher: T.I.N.A. There is no alternative[5]. Nessun partito di massa a livello europeo pare realmente convinto a mettere in discussione la logica del riarmo contro il potenziale invasore russo[6] (ma anche contro potenziali invasori che arrivano dall’Africa[7]). Ora: è chiaro a tutte le persone di buon senso che Vladimir Putin non è una persona con la quale imitare Louis CK a tavola bevendo del buon vino[8]. È altrettanto chiaro, tuttavia, che la corsa al riarmo preparerebbe l’Europa ad un indirizzo politico di guerra, senza nemmeno la particolare necessità di chiedersi da che cosa ci stiamo difendendo e che cosa stiamo proponendo. È altrettanto chiaro che non c’è alcuna ragione etica dietro la difesa dell’Ucraina se non un perverso gioco verso una linea rossa tuttora da stabilire (pensare che esista una guerra giusta è un’aporia in termini[9] se non esiste un dopo la guerra: il paragone tra la Resistenza Italiana e quella Ucraina risulta fallace nella misura in cui se la Resistenza Italiana non combatteva in nome dello stato-nazione italiano ma per un futuro fatto di precise istanze politiche, cosa che rende l’esperienza Resistenziale Italiana peculiare e non paragonabili alle odierne Resistenze[10] – siano esse provenienti dal Medio Oriente o dall’Est Europa).[11]
Che cosa stiamo proponendo? In nessun partito di massa viene messo in discussione l’ordine sociale in cui ci ritroviamo ad abitare. La western way of life (che è il regime di vita più diffuso in Unione Europea, ovviamente non considerando le marginalità) è considerata il massimo grado di progresso raggiungibile. Non importa, dopotutto, se ogni regime di vita è soggetto ad un precariato esistenziale dovuto a mutamenti dell’assetto di produzione (dal rigido regime post-fordista al flessibile regime neoliberale). Non importa se la delocalizzazione di interi settori produttivi porti nell’altra metà del mondo instabilità e morte, e che lo stesso supporto su cui sto scrivendo potrebbe essere stato parzialmente prodotto in condizioni schiavistiche in Congo[12]. Il capitalismo non è più un monolite (checché ne pensino i rossobruni[13] o la “cultura woke”[14]): il suo regime è la strumentalità e l’assoluto realismo. (dicevamo: There is no alternative. Che si tratti di “sparagli Piero, sparagli ancora” o di “Autobiografia industriale, viva le tette dell’industria culturale”[15]). Il fatto che un cittadino su 10 soffra di un disturbo mentale in UE e che è la prima categoria di malattie croniche (la fonte è il Ministero della Salute) non importa particolarmente[16]. Sì, è sicuramente vero che la western way of life è forse in questo momento il massimo grado di sviluppo che siamo riusciti a raggiungere. È altrettanto vero che l’impotenza riflessiva che le collettività sentono- rifugiandosi magari nel riflusso- sembra suggerire che non abbiamo altre prospettive, oltre a questo stile di vita che, da pochissimi semplici dati enumerati sopra, non sembra granché auspicabile. Eppure, l’incapacità di pensare oltre la western way of life è il triste sintomo di un tempo imprigionato nel suo tempo. Certo, è importante votare. Of course, but maybe, maybe… (vengono erette piramidi gigantesche).
Un tempo imprigionato nel suo tempo è un tempo che non ha alcun orizzonte simbolico[17]. Non riesce a trovarlo nel suo passato. Non è un caso che vengono riabilitate istituzionalmente a livello europeo echi di un passato di morte, dalla fiamma tricolore di Giorgia nostra ai rigurgiti neofascisti di Vox[18]. La destra europea sembra prendere pappe[19] di pensiero dal passato legittimandosi attraverso un discorso securitario (sempre più si parla di euronazionalismo[20] , concetto che ha superato di gran lunga i sovranismi alla Vannacci-Salvini).
Un futuro pare impossibile pensarlo: non esiste nessun partito europeo di massa che proponga seri mutamenti all’ordine sociale vigente o che non pensi in una logica strettamente legata al presente. Il futuro non è il sole dell’avvenire: è qualcosa che incombe. Il presente è un tempo che si autolegittima. Non è un caso che i grandi disturbi mentali del nostro tempo, ansia e depressione, sono legati ad una dis-percezione del tempo. La seconda in particolare si lega ad una negazione di quella che potremmo definire “la carezza dell’Altro”, alla negazione (per citare Bifo[21]) di una pro-tensione desiderante(non necessariamente sessuale) verso il corpo dell’Altro. Il tempo che si autolegittima è un tempo che cancella completamente dalla sua strumentalità l’alterità pura- dopotutto il desiderio non segue una logica strumentale, bensì una logica autoreferenziale[22] (e si dispiega in campi di forze che possono pure essere autodistruttive se il corpo si contrae nervosamente: l’elogio acritico del desiderio non aiuta comprendere l’intrinseco autoritarismo del nostro tempo. Si potrebbe andare a votare, of course, but maybe, maybe… (di nuovo, l’allergia alle noci).
Per questo provo disagio. Necessito di un’aritmia: un battito di tempo irregolare. Un’immagine inedita del futuro. Un nuovo montaggio.
C’è una scena in Zero in Condotta[23] di Jean Vigo che mi ha sempre emozionato. Ci sono dei ragazzini su un tetto. Sono in rivolta contro il sistema del collegio. Il primo di loro ha una bandiera in mano, pare il più deciso. L’ultimo di loro scivola, e si rialza immediatamente alzando una mano – che non mostra alcuna gestualità ideologica – verso la folla di bambini in rivolta. In quel brusco gesto (caduta disordinata- immediato rialzarsi) così apparentemente sgrammaticato, così apparentemente anti-cinematografico, c’è un movimento: come a sottolineare la necessità di quell’impaccio, come se quello scivolare quasi disprassico preannunciasse un braccio alzato che non voglia essere altro che gioia di partecipare alla rivolta, credere di essere uno zingaro felice. L’inquadratura stacca immediatamente, è una scena di pochissimi secondi. Eppure, tutto si condensa lì: la responsabilità di divincolarsi gioiosamente nel tempo e di guardare gli altri. Prendere una posizione con semplicità. Rimanendo bambini, ma con serissime intenzioni- dopotutto il gioco è la massima forma di serietà per i bambini.[24] È un’utopia, ma è necessario, per il mio disagio, in questo momento crederci.
Dice Zizek che siamo in una fase in cui più che cambiare il mondo è più importante interpretarlo. La retorica del “fare”, che si esprime per queste elezioni nella retorica del “votare” (anche se ormai pare che l’universo ideologico da cui si è circondati proponga una spinta verso un “fare”, un “utile”), è fallace nella misura in cui prima è necessario per un attimo comprendere sé stessi e le proprie mancanze, le proprie sintomatologie. Secondariamente è necessario tentare di concettualizzare il mondo in cui viviamo – impresa non facile, viste le evidenti contraddizioni in cui siamo immersi e di cui anche questo articolo risente.
Ma interpretare e autointerpretarsi costringe necessariamente ad una presa di posizione e di responsabilità attiva verso un futuro all’apparenza inesistente, ma che in realtà, a tutti gli effetti, esiste.
– Luca Martinelli
[1] da questo lungo attimo
inghiottito da nevi, inghiottito dal vento,
da tutto questo che non fu
primavera non luglio non autunno
ma solo egro spiraglio
ma solo psiche,(Andea Zanzotto, “Esistere Psichicamente” da “La Beltà”)
[2] L’analisi del voto come “rituale” è ben spiegata in un libro, provocatorio ma non troppo, del ricercatore canadese in sociologia Francis Depuis-Deri chiamato “Addio alle urne”
[3] Per approfondire, gli atti dell’Ottavo Congresso Mondiale di Psicanalisi tenutasi a Buenos Aires chiamato “L’ordine simbolico nel XXI secolo”
[4] Tratto dal celebre sketch di Louis CK presente in “Oh my god”. Verrà citato tra le righe più volte essendo uno sketch dal valore simbolico molto più alto di quello che si possa a prima vista pensare,
[5] Thatcher al Congresso delle Donne Conservatrici nel 1980. La frase diverrà poi d’uso comune in ambiente conservatore anglofono fino a diventare una sorta di leitmotiv in tutta Europa a partire dalla caduta del Muro di Berlino.
[6] Le spese militari nei paesi UE raggiungono circa i 224 miliardi di Euro (fonte Attac Italia). Le esportazioni di armi globali sono del 74 percento dei paesi Nato. L’Italia spende 28 miliardi di euro in armi ogni anno aumentando ogni anno la spesa militare dal 2016. Nel 2022(si presume la spesa sia aumentata ancora) la spesa militare globale ha superato quella della Guerra Fredda.
[7] L’accordo da 7,4 miliardi di euro con l’Egitto prevede che 200 milioni siano destinati al contrasto dell’immigrazione irregolare: l’ennesima opera di esternalizzazione della frontiera di cui parla bene Anna Fazzini in “Esternalizzazione delle frontiere e la responsabilità degli Stati Europei”.
[8] Basta leggere “L’ultima guerra dell’Isola-Mondo” di Dugin per capire il fascismo intrinseco nell’ideologia euro-asiatica della politica putiniana.
[9] In questo fondamentale leggere l’intervista di Elisa Cuter all’economista Emiliano Brancaccio sulla rivista della Treccani “Il Tascabile”
[10] Ciò non significa che il termine Resistenze sia errato per parlare di queste esperienze, ma che ogni Resistenza vada storicizzata(vd. “La tirannide dell’Io” di Enzo Traverso)
[11] Per una critica al concetto di Resistenza, si consiglia di leggere l’articolo “Per una critica della Resistenza” sul sito di Connessioni Precarie
[12] Su questo è folgorante l’incipit del pamphlet “Realismo Capitalista” del critico culturale Mark Fisher.
[13] Lasciamo a Diego Fusaro quel che è di Diego Fusaro, insomma. Ma è interessante come anche personalità dalla grande storia politica come Sarah Wagenknecht in “Contro la sinistra neoliberale” cadano nella trappola del rossobrunismo.
[14] Uso il termine cultura woke pur essendo un termine chiaramente destroide perché non esiste nulla se non il “Culturalismo di sinistra” proposto da Mimmo Cangiano per descrivere il progressivo deterioramento di una politica di sinistra incentrata sul mutamento dei rapporti di produzioni in favore di una sinistra culturalista che si rifugia in posizioni culturaliste e anti dialettiche (si consiglia di leggere “Guerre culturali e neoliberalismo” dello stesso Cangiano o “Capitalismo woke” di Carl Rhodes)Uso il termine cultura woke pur essendo un termine chiaramente destroide perché non esiste nulla se non il “Culturalismo di sinistra” proposto da Mimmo Cangiano per descrivere il progressivo deterioramento di una politica di sinistra incentrata sul mutamento dei rapporti di produzioni in favore di una sinistra culturalista che si rifugia in posizioni culturaliste e anti dialettiche (si consiglia di leggere “Guerre culturali e neoliberalismo” dello stesso Cangiano o “Capitalismo woke” di Carl Rhodes)
[15] Trattasi di due citazioni. La celebre “Guerra di Piero” di Fabrizio de André e la corrosiva “Autobiografia industriale” di Claudio Lolli.
[16] Il rapporto tra salute mentale e sistema economico-sociopolitico è stato appurato chiaramente da filosofi e analisti provenienti da diverse aree disciplinari quali Felix Guattari e Gilles Deleuze (“Capitalismo e schizofrenia”), Frantz Fanon (“La terra dei dannati”) ed Eugene Devereux (“Saggi di etnopsichiatria generale”).
[17] Su questo leggere lo studio di Giuliana Mandich pubblicato da Firenze University Press intitolato “Il futuro come utopia?”
[16] Assolutamente fondamentale in questo “Iconologie della destra, La propaganda figurativa da Almirante a Meloni” di Luciano Cheles.
[18] Furio Jesi e l’elaborazione del suo discorso sul mito, culminato in Cultura di destra, aiuta molto nella comprensione di questo fenomeno. Di recente è stata ripubblicato da Quodlibet “Mito”.
[19] Nel podcast di Startmag il professor Daniele Albertazzi spiega molto bene lo scarto tra euronazionalismo e sovranismo.
[20] Nel commovente articolo “In morte del compagno Fischer” Bifo spiega tutto ciò in maniera più chiara.
[21] Su desiderio e anticapitalismo, “Ripartire dal desiderio” di Elisa Cuter
[22] https://www.youtube.com/watch?v=Zmj_6JjE5gc
[23] Come diceva Nietzsche, “…nell’uomo autentico si nasconde un bambino che vuole giocare”

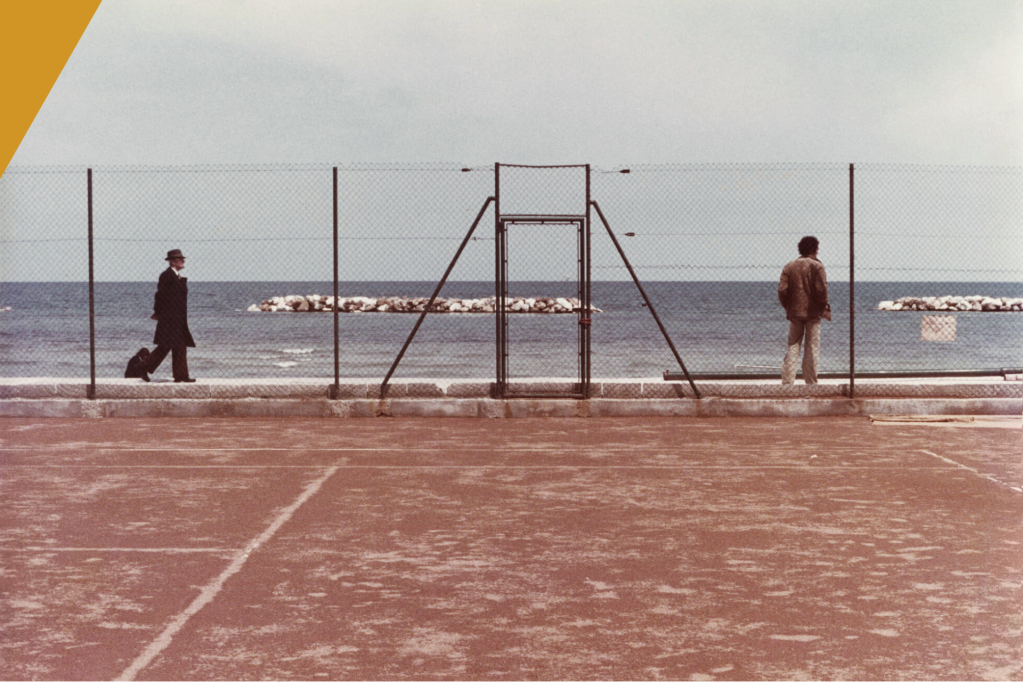

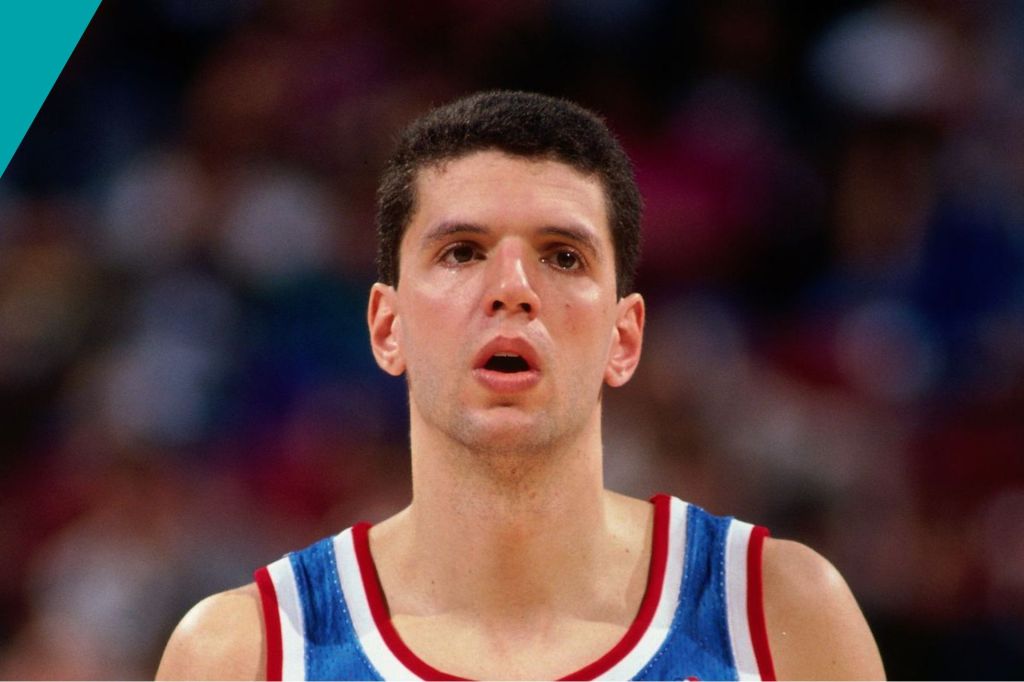
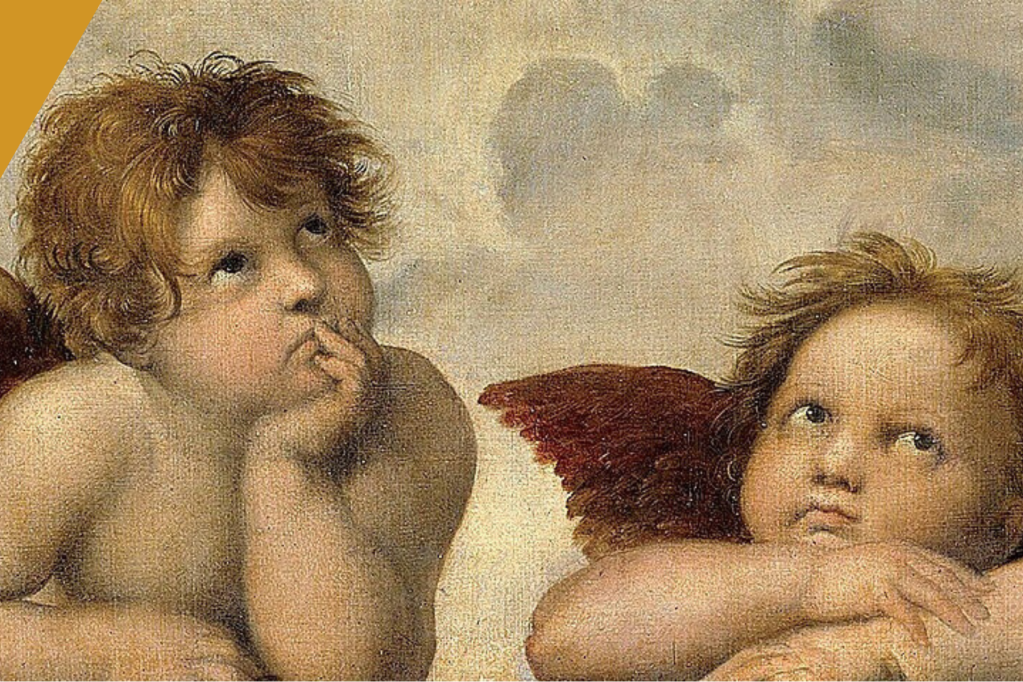
Lascia un commento