Gaber è un eclettico. Aldilà della forma artistica – che è di per sé un ibrido di vari filoni musicali e teatrali – è filosoficamente eclettico. Abbraccia e supera la scuola di Francoforte. Si incazza con la sinistra italiana e con i cattolici (saccheggia anche lui gli Scritti corsari di Pasolini). L’ironia, che secondo qualcuno diviene satira amara nell’ultima parte della sua carriera, è uno strumento filosofico antichissimo. Fa stand-up comedy mettendo in scena l’uomo del sottosuolo di Dostoevskij. È uno chansonier italiano autoironico, mai lamentoso o autocompiaciuto, una maschera che si plasma per rappresentare tutti senza diventare una macchietta anonima e banale. La grande libertà di Gaber sta anche in questo. Non risparmiare nulla, aggredire la realtà con una curiosità feroce, polemizzare con tutto e con tutti, ma rimanere fedele a un io ideale, ribaltando la definizione lacaniana, che è all’origine della vis gaberiana. Gettarsi in quest’avventura raffinatissima e popolare – chiunque può accedere al teatro canzone – non era una cosa da tutti: abbandonare una carriera in RAI di grande successo per tuffarsi nell’impresa del teatro canzone. Bisognava avere delle ragioni.
LA CRISI.
E c’era l’orgoglio di capire
E poi la certezza di una svolta
Come se capir la crisi voglia dire
Che la crisi è risolta(I reduci, 1976/1977)
Alla metà dell’opera di Gaber-Luporini è in atto una crisi generazionale. Non è una coincidenza che anche i due autori debbano rivedere il loro percorso (dal proverbiale addio alla televisione all’anno fatidico 1981). Racconterà spesso di quando andando a prendere in auto la moglie Ombretta Colli in Università (lei che studiava russo e cinese, lui cantante popolarissimo e showman a tutto tondo) si imbatteva negli sguardi degli studenti indifferenti al suo successo, ai suoi soldi, presi com’erano da una smania che poi ebbe modo di conoscere alle assemblee in Statale a cui partecipò con grande interesse. La prima parte del teatro canzone, in questo senso, è perfettamente ascrivibile alla temperie movimentista: il signor G che faceva capolino in canzoni come La corsa, La Chiesa si rinnova e Suona chitarra, non ha più paura di venire allo scoperto.
“Non so più se sono un cantautor-presentatore, o un presentacantautore, o un autopresencantante”
È il lascito del ‘68. Ma Gaber è già più avanti. Alla soglia degli anni Ottanta aveva già cantato “Chiedo scusa se parlo di Maria” a un evento per la Cambogia. Aveva già portato il suo “Tic” in televisione e “La libertà” era stata fraintesa e cantata da ogni schieramento politico. Il teatro canzone procedeva da qualche anno con estenuanti tournée a cui sacrificò anima e corpo. L’estate le lunghe giornate di lavoro con Luporini in Versilia a discutere del mondo e a scrivere gli spettacoli della stagione successiva. Tutto registrato dal vivo: non una sbavatura, una nota sbagliata; ogni muscolo del corpo impiegato nel veicolare le prose e le canzoni con tutte le loro sfumature di senso. Ma il duo, fin dall’inizio, poteva funzionare solo con un dialogo, onesto e acceso, fatto anche di contestazione, sedie vuote dopo il primo brano e accuse pesanti in risposta alle provocazioni del signor G. Insomma, qualcosa stava emergendo: un’insofferenza legata non tanto ai “buoni sentimenti” dei giovani del movimento studentesco ma alla delusione rispetto ai suoi esiti. Il conformismo, l’odio cieco di alcune frange, l’ipocrisia di tanti partecipanti. Ma prima di mettere a fuoco la questione della libertà – che, se non si fosse capito, è la chiave di volta del teatro canzone – bisogna approfondire questa crisi.
LA LIBERTÀ OBBLIGATORIA.
“A me l’America non mi fa niente bene, troppa libertà
Bisogna che glielo dica al dottore, a me l’America
Mi fa venir voglia di un dittatore, uh!
Sì, di un dittatore, almeno si vede, si riconosce
Non ho mai visto qualcosa che sgretola l’individuo come quella libertà lì Nemmeno una malattia ti mangia così bene dal di dentro
Come sono geniali gli americani, te la mettono lì
“La libertà è alla portata di tutti, come la chitarra
Ognuno suona come vuole, e tutti suonano come vuole la libertà”
(L’America, prosa, 1976)
La riflessione sulla libertà è centrale nella produzione di Gaber e Luporini. Aldilà di “libertà è partecipazione”, il signor G fa emergere i paradossi del nostro sistema libero e democratico:
Ed eccoci qui anche noi, liberi, liberali, liberisti, siamo per la rivoluzione liberale, ma con la solidarietà, siamo liberistici e per il liberalismo, siamo liberaloidi, libertari, libertini, libertinotti. Liberi tutti!
(L’America, prosa, 1995/1996)
Nel monologo “La Democrazia” si parla dell’inefficacia del sistema rappresentativo, di quanto sia ipocrita difendere acriticamente, sempre, a spada tratta, la democrazia (che è un meccanismo fragile e non mette al riparo gli uomini dal peggio). Ma c’è un aspetto più sottile di questa libertà “obbligatoria” che vale la pena evidenziare. In “Quando lo vedi anche” (1976) ci stupiamo, guardandoci allo specchio, di quanto le mode siano pervasive e sintomo di un pericolo immenso: lo smarrimento della libertà.
Quando lo vedi anche
Sulla tua maglietta
Sulle scarpe da tennis
Sui blue-jeans da quattordici once
[…] Noi così creativi, così assuefatti
Ci aggrappiamo ad un gesto che sembra di rotturaCon l’illusione e il pretesto di scegliere ancora
Noi così originali e spappolati
Creiamo saltando liberi come pidocchiCoi nostri gusti schifosi accumulati
Fra la testa e gli occhi
Ormai sei soggetto a una forza
Che ti è sconosciuta
Ormai sei libero e schiavo
Ormai sei coinvolto
E di colpo ti viene il sospetto
Che in tutta la vita
Non hai mai scelto
“Quando è moda è moda” (1978), apparentemente più politica, in collisione con tutto il mondo movimentista degli anni affollati tra il ‘68 e il ‘78, dice le cose come stanno: è un brano che non risparmia nessuno (un po’ come “Io se fossi Dio”), polemico, che coinvolge tutti – “quando è moda è moda, non c’è nessuna differenza”.
Dalle mode degli ultimi anni emerge chiaramente quanto i modelli del passato ritornino – basti vedere le varie operazioni nostalgia. Sembra che non si riesca a inventare più nulla di nuovo (un aspetto cruciale di quello che chiamano postmodernismo). Dai vestiti alle idee: si può ancora essere liberi oggi, essere diversi ma non certamente soli?
L’APPARTENENZA.
Com’è cambiata questa camera, prima era un casino di fogli foglietti, tutto al muro, manifesti, Marx Engels, attaccati male. Partiva un chiodo, e bluf, giù un testone, e poi prima che torni la giornata del chiodino… no, una bella imbiancata e via.
Fa tristezza, tz, è abitudine, il mio bell’armadione, lo specchio… va be’, spogliamoci, va. Che faccia ragazzi, le spalle curve, le gambe magre, e queste mutande, pervinca, mah questa volta va a finire che lo faccio davvero.(Il suicidio – prosa, Polli d’allevamento, 1978/9)
Il suicida sembra un altro disilluso, uno che credeva in quei testoni che cadono giù inesorabilmente. Non gli basta più la compagnia degli amici, le risate, e tornato a casa decide di farla finita. È slegato dal mondo, lo vorrebbe docile ai suoi piedi, come un cocker. Ma prima che si ritorni a farsi delle convinzioni, una coscienza nuova di zecca, “prima che torni la giornata del chiodino…” Sembra non esserci più speranza. Anche lui non appartiene più a nulla.
L’appartenenza non è uno sforzo di un civile stare insieme,
non è il conforto di un normale voler bene, l’appartenenza è avere gli altri dentro di sé, […] L’appartenenza non è un insieme casuale di persone, non è il consenso di una apparente aggregazione,
l’appartenenza è avere gli altri dentro di sé, […] È un’esigenza che si avverte a poco a poco Si fa più forte alla presenza di un nemico
Di un obiettivo o di uno scopo.
È quella forza che prepara al grande salto decisivo
Che ferma i fiumi, sposta i monti con lo slancio di quei magici momenti
In cui ti senti ancora vivo.
Sarei certo di cambiare la mia vita
Se potessi cominciare a dire “noi”.
(Canzone dell’appartenenza, La mia generazione ha perso, 2000)
Quando non c’è nessuna appartenenza:
La mia normale, la mia sola verità,
è una gran dose di egoismo magari un po’ attenuato da un vago amore per l’umanità. Tutto quello che provo è una vana protesta,
è solo questa mia coscienza che non mi basta.
Forse ci vorrebbe:
Un egoismo antico e sano di chi non sa nemmeno che fa del bene a sé e all’umanità.
(Canzone della non appartenenza, E pensare che c’era il pensiero, 1994)
Qui, in un certo senso, il discorso sull’«io» e la coscienza si riallaccia al «noi» degli album più politici (quelli degli anni di piombo fino all’‘81, col giro di boa di cui si è già detto). Era caduto da pochi anni il muro di Berlino, il panorama politico era rinnovato – almeno nella forma – e l’impegno civile acquisiva nuove forme: la solidarietà attraverso il volontariato, l’associazionismo con la lotta alle mafie (sono anni di stragi), il movimento no global che salirà agli onori della cronaca nel 2001 con la tragedia del G8, e anche il fiorire di movimenti cattolici intorno a queste tematiche (la figura carismatica di Giovanni Paolo II) Insomma, lo sfarinamento dei partiti, degli apparati sindacali e politici, dei cosiddetti “corpi intermedi”, è il segno della fine del Secolo. Gaber riporta ancora una volta al centro l’«io» in un momento in cui il «noi» delle grandi organizzazioni e movimenti di massa del Novecento sembra essere stato completamente archiviato. Eppure l’uomo della fine del secolo ne ha ancora bisogno: bisogna credere, credere bene, ancora una volta. Il signor G lancia quest’«io» liberato dalle sovrastrutture del secolo delle ideologie, oltre il tempo presente (“Se ci fosse un uomo”, 2000). Premesso che:
In uno dei miei rari momenti di lucidità
Mi sono guardato allo specchio
E mi sono accorto che il mio pensiero, aveva bisogno di un lifting
Al momento ho attribuito questa mia défaillance, a un mio precoce rincretinimento senile Poi mi sono guardato intorno e
No, non che mi sia sentito intelligente, però mi sono consolato
Ecco ho capito, che un uomo oggi meno esprime il suo pensiero, meglio è
Tutt’al più può esprimere un parere
Ma i pareri si sa, sono come i coglioni
Ognuno c’ha i suoi […]
(Questi nostri tempi, E pensare che c’era il pensiero, 1994)
Parlare di appartenenza oggi sembra una follia. Con internet le nostre relazioni, il modo in cui ci aggreghiamo, è diventato quasi del tutto virtuale, leggero, immediato. Non ci sono più quelle impalcature ideologiche e burocratiche che tenevano insieme le masse organizzate del secolo scorso. Il signor G lancia la sua provocazione e quatto quatto se ne va.
FINALE (PROSA).
Io c’ho un amico, è un ragazzo giovane, intelligente preparato, molto preparato. E, non gli va mai bene niente. Mai. Le canzoni, lo spettacolo, il finale. Un rompiballe insomma, lui mi fa, lui dice, “va beh, tu vuoi arrivare al negativo, alla distruzione, all’autodistruzione, forse potrà anche servire a qualcosa, forse. Ma poi” e aggiunge forte “ce l’hai il biglietto di ritorno?” Ma, non capisco, cosa vuole da me? Non vorrà mica un’indicazione, un risvolto positivo, una soluzione. No. non ho il biglietto di ritorno, e poi comunque, dico comunque, fatto da me, da qui sopra, su un palcoscenico, un po’ in alto no, sarebbe sempre, un biglietto cumulativo, cioè di quelli che li fa uno per tutti no. Basta! Io credo che ognuno, debba guardare molto, dentro di sé. Solitudine? No, un momento necessario, perché quello collettivo sia un gesto naturale, non velleitario. Voglio dire, si d’accordo, tutti insieme, tutti sullo stesso treno. Ma ognuno col suo biglietto. (Finale, prosa, 1973/1974)
– Paolo Colucci

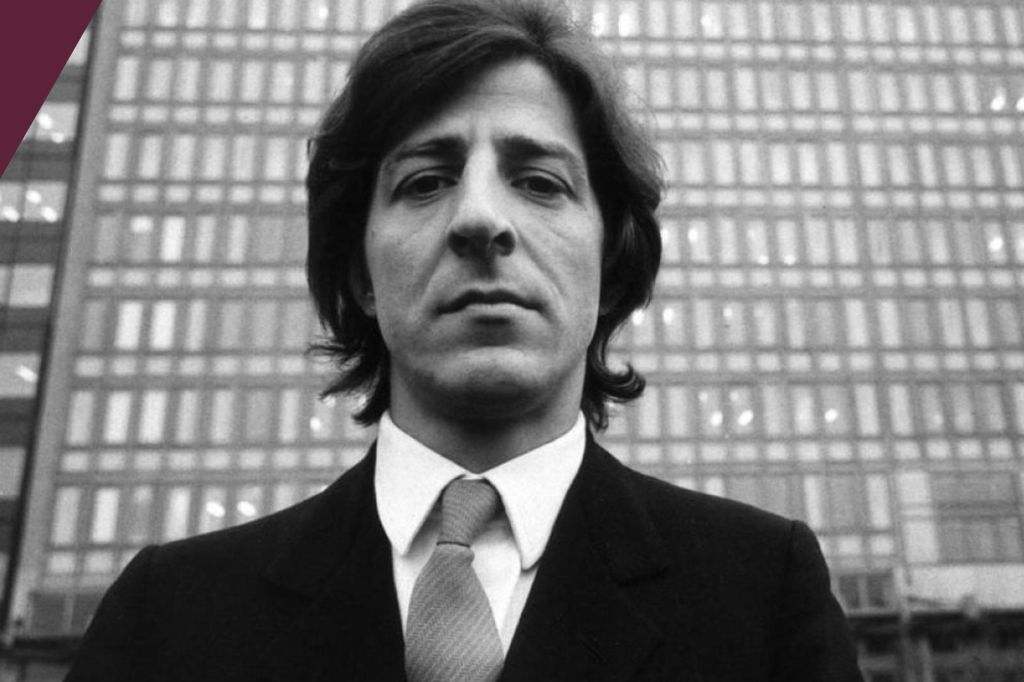
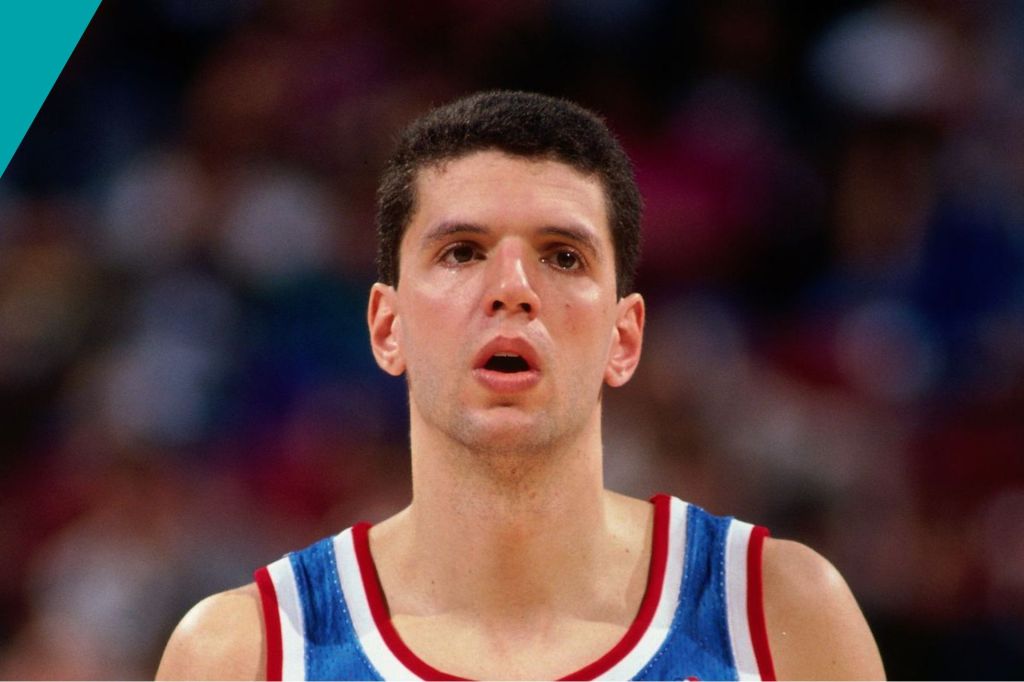
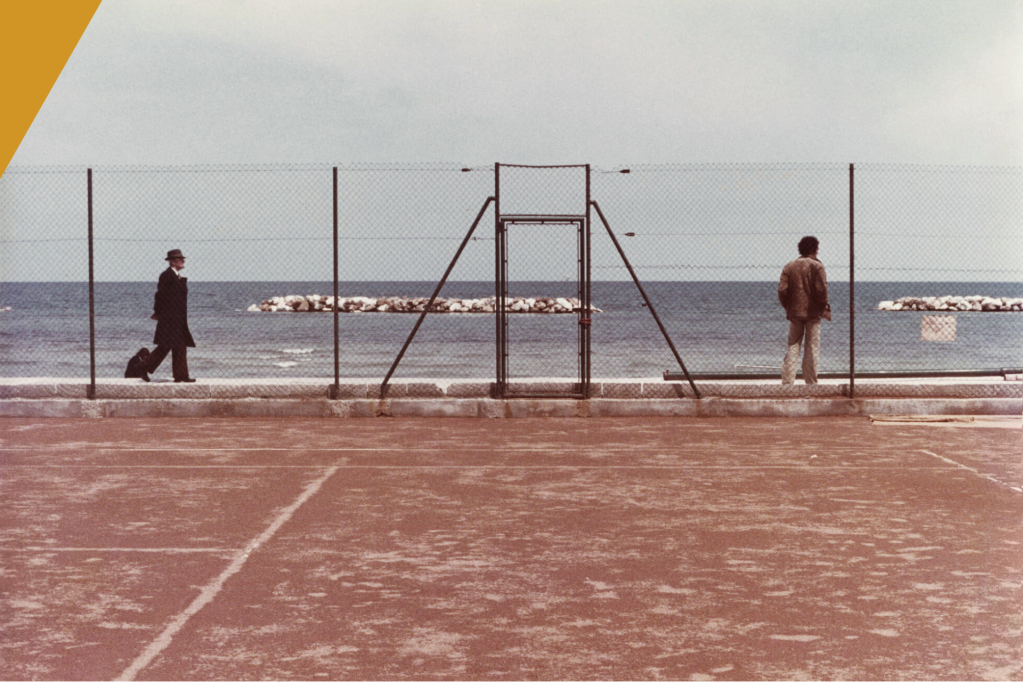
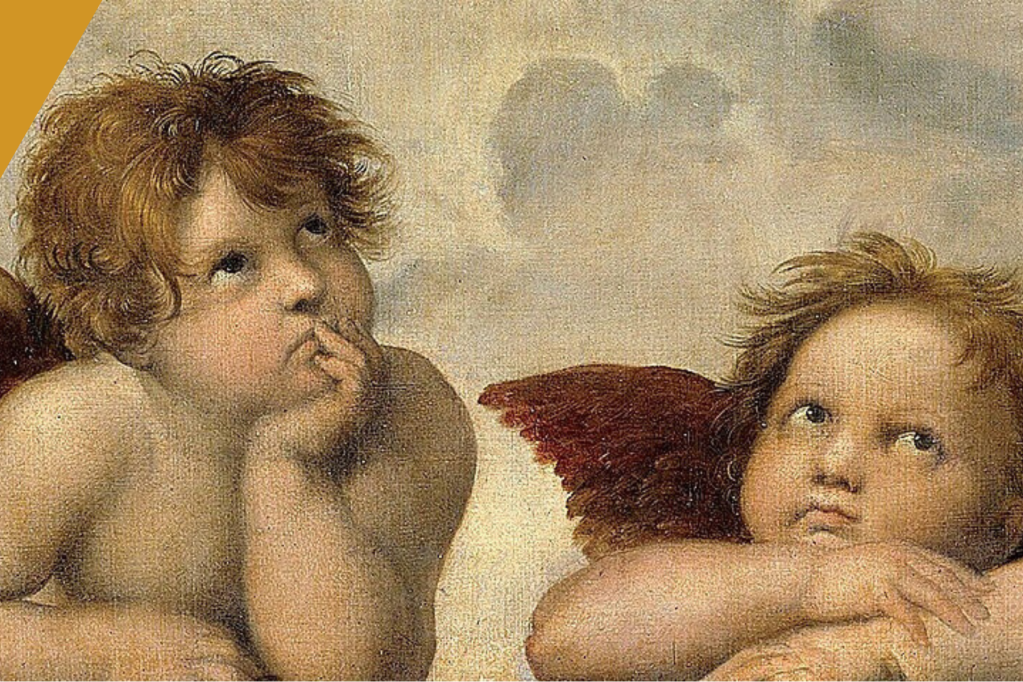
Lascia un commento